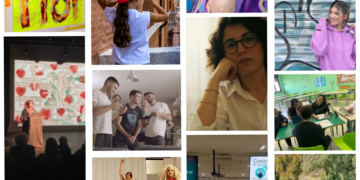Nasciamo tendenzialmente creduloni eppure impariamo prestissimo a dire le bugie. Perché lo facciamo? Di questo e molto altro si indaga nel libro “La mente di Pinocchio: Neuroscienze fra memoria, bugie e fake news” a cura di Gianfranco Denes, medico neuropsicologo e neurolinguista, docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Edita da Il Pensiero Scientifico, l’opera è stata presentata lunedì mattina a Cagliari, nella Sala Conferenze dell’Exmà, in occasione della XVI edizione del FestivalScienza, promosso dall’associazione ScienzaSocietàScienza e dedicato al tema “Scienza in Movimento“.
Assente per via del Covid, l’autore – collegato in diretta streaming – ha spiegato al pubblico cagliaritano che constava principalmente delle studentesse e degli studenti dell’Istituto “De Sanctis – Deledda” di Cagliari, com’è nata l’idea del libro: “Nella mia esperienza di medico ho incontrato molti pazienti che avevano subito un danno alla memoria e questo li portava spesso a dire bugie, che derivavano prevalentemente dall’amnesia. Tutto ciò ha fatto nascere in me il desiderio di indagare quali fossero i meccanismi cerebrali che ci permettono di dire bugie”.
La bugia – infatti – nella maggior parte dei casi è un atto volontario e consapevole con cui presentiamo agli altri una falsa verità. Tuttavia può dipendere anche da altre circostanze, come per esempio dall’aver subito un danno cerebrale i cui effetti negativi si sostanziano nelle amnesie, che possono – a loro volta – portare alla produzione di bugie.
Va detto però che non tutti sono abili bugiardi: ci sono bravi bugiardi e cattivi bugiardi. “Per dire una bugia – infatti – occorre fare uno sforzo non da poco”, precisa il professore, e aggiunge: “Quando mentiamo si attivano dei meccanismi complessi in termini neurologici e funzionali che consentono di contraddire il principio di verità”.
La bugia non emerge spontaneamente come accade con la verità, ma necessita di almeno tre componenti che giocano un ruolo fondamentale nell’elaborazione della stessa: l’inibizione della risposta vera, lo spostamento della risposta da quella vera a quella falsa, e il mantenimento delle stesse (sia quella vera che inventata) in memoria mentre si formula la suddetta risposta falsa.
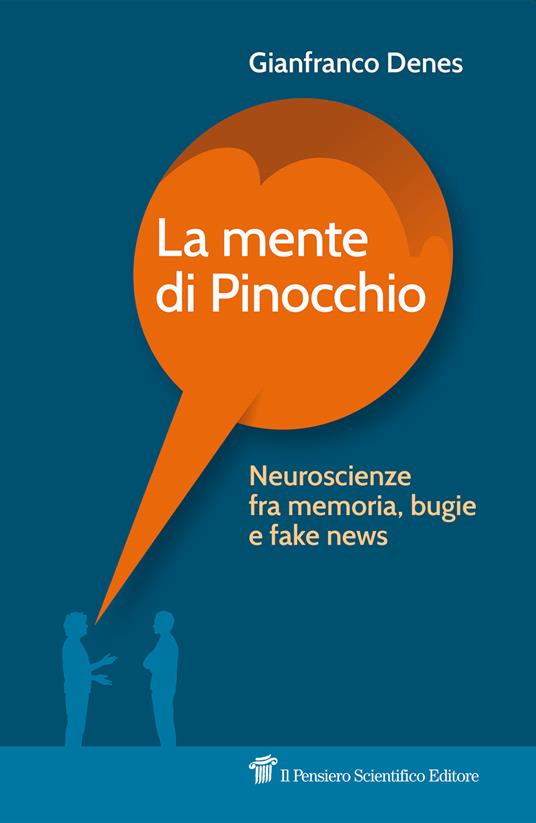
Si tratta quindi di una procedura tutt’altro che semplice dal momento che coinvolge il sistema di memoria, sia a lungo che a breve termine, e che si regge su una serie di altre e ulteriori valutazioni: per esempio la capacità di intuire lo stato mentale della persona cui la bugia è diretta. La menzogna infatti deve essere ben costruita, non esagerata e quindi plausibile, per scongiurare la paura che venga etichettata immediatamente come fandonia, con la conseguenza di venire scoperti.
Per questo motivo alcune persone non sono brave a mentire, non perché siano di per sé contrarie, ma proprio perché a livello neurologico non risultano capaci di compiere quei meccanismi complessi che la bugia richiede. Ne sono un esempio i malati di Alzheimer e coloro affetti da patologie rientranti nello spettro autistico.
Per quanto abituati a credere che ci venga detta la verità, mentiamo con molta facilità. Iniziamo da piccoli, quando avvicinandoci una banana all’orecchio adoperiamo la finzione per giocare e fingiamo che sia la cornetta di un telefono, oppure utilizzando il famoso imperfetto narrativo: “Facciamo che io ero la mamma e tu il papà”.
In media diciamo circa 4/5 bugie al giorno, che possono essere di diverso tipo: possiamo per esempio rivolgerle a noi stessi, come nell’autoinganno, oppure agli altri. Per difenderci da ciò che accade all’esterno tendiamo spesso a costruire nella nostra mente situazioni che non corrispondono alla realtà, che spesso dissipano le nostre paure e che diventano – di fatto – delle nuove realtà.
Così facendo siamo anche un facile bersaglio delle cosiddette “fake news”, alimentate dallo scollamento crescente che coinvolge la memoria e la storia (i fatti per come sono accaduti realmente), e che trovano terreno fertile nel marasma delle informazioni in circolazione, per cui siamo portati ad affidarci a contenuti che meglio corrispondono ai nostri bisogni e desideri.
Come ci si difende da tutto questo? Impegnandoci a eliminare qualunque forma di preconcetto tutte le volte in cui si affronta un argomento, diffidando sempre da informazioni che appaiono troppo sicure e poco ragionate e confrontando le fonti.
LEGGI GLI ALTRI APPROFONDIMENTI SUL FESTIVAL SCIENZA