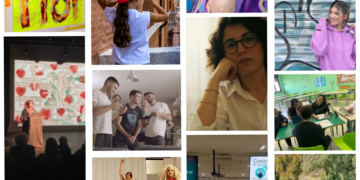Nel territorio di Cagliari, nel Miocene, milioni di anni prima della comparsa dell’uomo, c’erano i coccodrilli come il ‘Tomistoma’ calaritanum, ma anche gli squali come il gigantesco megalodonte. A Jerzu, nel Giurassico, gli ittiosauri. A Gonnesa, nel Pleistocene, quando in Africa apparvero i primi uomini moderni, il Mammuth nano e il cervo megacero. Tutto questo, e molto altro ancora, è raccontato nella Pagina Facebook Animali e piante fossili della Sardegna, creata dal paleontologo del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari Daniel Zoboli con “l’obiettivo di divulgare in maniera semplice e chiara la paleontologia (e la geologia) della Sardegna”. Tante sono le curiosità sulle forme di vita custodite nelle rocce della “terra più antica d’Italia”. Alcune le abbiamo soddisfatte, con un’intervista che spazia dal racconto della professione di paleontologo a quello del contesto sardo, un territorio tutto ancora da valorizzare in chiave geoturistica.
Due anni fa ha aperto la pagina Animali e piante fossili della Sardegna. Come è nata l’idea di questo spazio divulgativo?
È nata per gioco. Su Facebook le pagine e i gruppi dedicati alla geologia, alla paleontologia e soprattutto alla paleontologia sarda sono pochi. La pagina sta crescendo, post dopo post. La seguono persone di tutte le età, sarde, da tutta Italia e da diverse parti del Mondo: da tutta Europa, specie dalla Francia, per lo stretto legame geologico tra Sardegna e Corsica, ma anche dagli Stati Uniti, dal Sud America, da Cina e Giappone.
C’è un certo fascino intorno alla professione di paleontologo. Perché i più piccoli mostrano curiosità verso creature estinte milioni di anni fa?
Il fascino è legato in larga parte al mistero: il paleontologo è il primo a mettere gli occhi su un resto animale o vegetale che non vede la luce da milioni di anni. Ma vi è anche un fascino legato ai grandi animali preistorici del passato, i dinosauri, che esercitano sempre una grande attrazione. C’è una sorta di “timore reverenziale” nei confronti di questi grandi animali. Non a caso, sono nate le grandi epopee giurassiche al cinema, che hanno conquistato i bambini, da ‘Jurassic Park’ nel 1993 al più recente sequel ‘Jurassic World’.

Come sono organizzate le ricerche di fossili? Il paleontologo è un ricercatore solitario, oppure si muovono dei gruppi di ricerca?
È sempre meglio andare in gruppo per ragioni di sicurezza. Molto spesso si va in zone molto isolate. Occorre pianificare le spedizioni, specie in territori estremi, come le aree desertiche della Mongolia, dell’Africa o delle Americhe, dove andare da soli è impensabile. Occorre studiare il territorio con le carte geologiche, capire le tipologie di rocce che affiorano in quell’area. I fossili, ovviamente, si trovano nelle rocce sedimentarie. Le grotte, poi, sono dei luoghi dove è possibile trovare resti fossili di animali lì intrappolati da centinaia di migliaia di anni.
La scoperta come avviene? È una scoperta ragionata o c’è una certa percentuale di fortuna?
Il 90% è fortuna. Dipende comunque da cosa si sta cercando. Se si va sul terreno per campionare delle rocce nelle quali si sa già di trovare fossili di piccoli organismi (es. microfossili) il successo è quasi sempre assicurato. Più difficile è la ricerca di animali di grandi dimensioni, come i dinosauri. In Sardegna non ne sono stati ancora scoperti, ma c’è la concreta possibilità di trovarli nelle rocce risalenti all’era mesozoica, presenti nell’Isola: nel Sulcis, nell’area di Sant’Antioco e Porto Pino abbiamo rocce risalenti al Giurassico e al Cretaceo, oppure anche nell’area di Alghero – Capo Caccia, o anche nella Sardegna Centrale, dal Golfo di Orosei fino all’area dei Tacchi, tra Ulassai e Jerzu, fino al Supramonte. Alcune di queste zone non sono facilmente accessibili, ma prima o poi sarà effettuata una qualche scoperta. Ed è davvero strano che non sia avvenuta finora: se andiamo a vedere l’ “evoluzioni paleogeografica”, la Sardegna e la Corsica sono una piccola parte dell’Europea continentale, che si è allontanata da essa in tempi relativamente recenti, intorno ai 15 – 20 milioni di anni. Prima di tale allontanamento, Sardegna e Corsica si trovavano a ridosso delle coste francesi e spagnole ed avevano una fauna pressoché identica a quella europea. La Francia meridionale e la Spagna nord-orientale sono tra le aree più ricche di fossili di dinosauri in Europa.

Quali sono i principali musei sardi di paleontologia, per scoprire oggetti e animali rinvenuti nelle rocce fossili dell’Isola?
Il Museo Sardo di Geologia e Paleontologia D. Lovisato dell’Università di Cagliari , con il quale collaboro, è un museo tecnico, con reperti dal grande valore scientifico: ha rocce e fossili di provenienza esclusivamente sarda, ma per il visitatore “occasionale” ha probabilmente più appeal il PAS – E.A. Martel, a Carbonia. Un museo di più ampio respiro dove, accanto a fossili del Sulcis Iglesiente, datati più di mezzo miliardo di anni fa, i più antichi d’Italia, si trovano fossili da tutto il mondo tra cui una riproduzione a grandezza naturale dello scheletro del famoso Tyrannosaurus rex. E ancora, a Masullas vi sono due musei: il Museo Aquilegia di scienze naturali, con una sezione dedicata alla paleontologia e una riproduzione di allosauro; il GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani”, connesso al territorio, che custodisce reperti di epoca miocenica, legati ai vulcani e all’ossidiana. Vicino alla Giara, a Genoni c’è il Museo P.AR.C., collegato al geosito Cava Duidduru, una vecchia cava recuperata in funzione geoturistica. A Nuoro, al Museo Archeologico, c’è una sezione di paleontologia dove sono in esposizione fossili, di età quaternaria, rinvenuti nella zona di Orosei: resti fossili di piccole scimmie, capre primitive e della iena sarda. Anche al Museo Archeologico Sanna di Sassari c’è una sezione paleontologica, dove sono presenti dei calchi di ominidi e resti di cervi ritrovati nella Grotta Corbeddu di Oliena, mentre al MAP Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas è possibile vedere fossili di piante mioceniche dell’Anglona. In Sardegna non mancano nemmeno le piccole collezioni come ad esempio quella del Sito Geo Speleo Archeologico Sa Marchesa di Nuxis.

È un patrimonio rilevante questo. Cosa c’è ancora da fare per valorizzarlo?
La Sardegna ha tanti geositi che, se non vengono messi in sicurezza, potrebbero subire un degrado naturale o peggio essere danneggiati. L’ideale sarebbe realizzare una rete tra musei e territorio (il geosito collegato al museo), come è stato già fatto a Masullas o Genoni, grazie alla sensibilità delle amministrazioni comunali, per avviare delle attività di geoturismo. Anche a Cagliari, dove vi sono tantissimi affioramenti di rocce fossilifere situati nei colli, potrebbe prendere il via un geoturismo urbano. Sarebbe possibile promuovere una sorta di tour, che parte dal Museo Lovisato per poi muoversi “sul campo” nei vari colli e aree di interesse geologico della città.
(Nella foto in evidenza il paleontologo Daniel Zoboli mostra il calco del cranio del coccodrillo miocenico “Tomistoma” calaritanum, ritrovato nell’area di Piazza d’Armi a Cagliari e conservato nel Museo Domenico Lovistato di Cagliari)