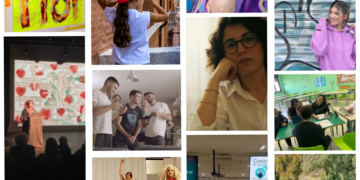Cosa è cambiato nella comunicazione culturale con la pandemia? Quali sono le novità e quali i cambiamenti nel mondo della comunicazione? Queste e altre domande hanno trovato spazio in uno dei workshop gratuiti proposti dal festival Pazza Idea in questi giorni a Cagliari per la sua decima edizione: a curarlo il giornalista Antonio Prudenzano, che partendo dalla sua esperienza professionale ha analizzato cambiamenti e tendenze nella comunicazione della cultura.

Tante le differenze del giornalismo culturale rispetto a pochi anni fa: oggi nascono e crescono testate che vivono solo online e sui social. L’informazione via web, ha sottolineato Prudenzano, deve capire che c’era bisogno e c’è tutt’ora uno spazio libero e diviene fondamentale analizzare cosa c’è intorno e cosa manca. Se prendiamo in esame la fruizione della cultura, ad esempio, notiamo che la pandemia ha penalizzato enormemente musica e teatro e invece ha permesso di avere più tempo per il libro e la lettura; la chiusura delle sale ha portato all’aumentare di piattaforme di streaming con un cambio di abitudini: escono molti film ma i film hanno meno spettatori. Tante le proteste del settore, come quella “Bauli In Piazza” a Roma e Milano che hanno invocato la riapertura piuttosto che la ripartenza nelle piattaforme come Zoom.
LEGGI ANCHE: Creatività, questa sconosciuta. Stefano Bartezzaghi a Cagliari per la prima giornata del festival Pazza Idea
Sono aumentate le testate on line e anche i blog personali: in generale sono sempre di più le persone che navigano in rete in Italia, ma questa diffusione di internet non è uguale ovunque e non per tutti, dato che esistono persone che non hanno accesso neanche ai servizi di base come la semplice prenotazione di visite mediche.
Un discorso a parte meritano le piattaforme di film e video in abbonamento streaming: guardiamo sempre meno canali tradizionali e cerchiamo continue novità. Il successo maggiore si raggiunge con le live che raccontano la quotidianità. Il pubblico web non cerca un prodotto perfetto ma predilige chi racconta la propria quotidianità con naturalezza e video imperfetti a “dimensione casalinga”.

La fruizione della cultura on line può essere uno strumento prezioso anche per festival e Università ma con un grande rischio: su web le differenze si appiattiscono ed è difficile per alcuni fruitori distinguere realtà poco preparate e competenti rispetto a quelle più autorevoli.

Se il teatro a distanza non ha funzionato durante la pandemia, abbiamo invece registrato una riscoperta della lettura non solo su carta ma anche in ebook: prima della pandemia i lettori forti leggevano 15 libri all’anno, ora ne leggono 17, chi aveva smesso di leggere ha ripreso, e anche i sistemi bibliotecari hanno aumentato la possibilità di avere più lettori. E gli audiolibri stanno conoscendo una crescita esponenziale. Il settore è rimasto in piedi anche grazie all’adozione di misure come il “bonus cultura” e lo stato ha agevolato economicamente le librerie indipendenti. Il lavoro del libraio è un lavoro, secondo Prudenzano, mitizzato ma è soprattutto un lavoro “fisico”, è una impresa a tutti gli effetti. A gennaio del 2022 il governo istituzionalizzerà dei finanziamenti per i lettori forti e questo permetterà all’intero settore di resistere maggiormente. All’interno di questo quadro c’è il “caso Sardegna”, una regione dal grande fermento culturale e interesse verso la lettura perché l’utenza è più sensibile. Il Salone del Libro di Torino poi è una realtà magica e unica in Italia che con fiducia e passione quest’anno ha registrato un record di presenze nonostante la paura della pandemia.
Il mondo dei bookinfluencer ha registrato un boom: in tutto il mondo il blog è stato sostituito da chi comunica negli spazi social con un’offerta vastissima; se prima le case editrici investivano in pubblicazioni e recensioni sui giornali ora si sostengono i “bookinstagrammers”.