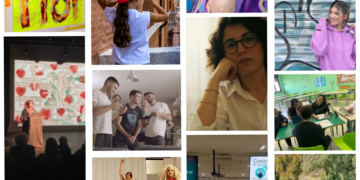Quando un giornale chiude, sia esso cartaceo o online, sparisce un mondo. E se sparisce un mondo, scompaiono anche quelle diversità culturali che lo abitano. Si dissolve la loro voce e tutto ciò che può essere espresso e trasmesso.
In tempi nei quali, al contrario, avremmo maggiore bisogno di voce, date le problematiche non solo locali ma mondiali che vanno a minare l’identità di popoli, la loro stessa esistenza e la loro libera espressione, noi che ci occupiamo di cultura, ci dobbiamo arrendere alle dinamiche del sistema, dove la cultura stessa, l’identità, le libertà espressive, per l’appunto, non risultano più attraenti, non sono abbastanza ‘influencer’ e non diventano ‘virali’, per dirla col linguaggio attuale. E di conseguenza, se vuoi vivere, o meglio, sopravvivere di cultura, ognuno fa da sé e dunque le idee, i progetti, inesorabilmente, si trasformano in realtà non sostenibili.
Questo accade non solo alla stampa e all’informazione, online e offline, ma anche agli spazi fisici dove la cultura tenta di vivere e resistere. Pensiamo ad esempio alla chiusura massiva nell’ultimo decennio di cinema, teatri, biblioteche, centri e circoli culturali, anche autogestiti, che rappresentano tuttavia degli ottimi contenitori di fruizione culturale, creatività e divulgazione.
E se estendiamo il ‘fenomeno’ osservandolo nell’insieme vi è la percezione che forse la cultura, spostandosi dagli ambienti fisici, stia diventando in misura crescente un qualcosa di immateriale, più legata a nuove forme di interazione e relazioni con valori, idee e norme comuni ma che attualmente parrebbe non necessitare più di un ambiente fisico per esprimersi.
Nonostante questo la cultura rappresenta ancora un possibile motore di cambiamento in grado di stimolare processi creativi e innovativi e soprattutto può fare da leva di coesione sociale e sviluppo economico.
Secondo Tullio De Mauro, linguista, lessicografo, saggista e Ministro della Pubblica Istruzione 2000-2001, la cultura rappresentava un complesso di conoscenze intellettuali e nozioni che contribuiscono alla formazione della personalità dell’individuo. Per lui risultava fondamentale considerare l’aspetto sociale, ovvero le abitudini, le credenze, le capacità e le norme che un individuo acquisisce come membro di una società.
Nei suoi saggi De Mauro ha analizzato il significato di sapere e cultura in relazione ai cambiamenti sociali, culturali e informativi del Novecento, scrivendo:
«Noi ci proponiamo qui di chiamare cultura qualunque forma di vita che non sia prevista come obbligatoria dal patrimonio genetico di una specie, anche se, evidentemente, non contraddice a questo patrimonio. […] Questa definizione così generale lega ciò che chiamiamo cultura al mondo del vitale; del vitale e non, almeno in modo specifico, al solo mondo umano».
E in seguito scrive: «Non solo gli umani, ma anche altre specie animali hanno la capacità di trasmettere da una generazione all’altra informazioni per via non genetica, cioè per via di ammaestramento e comunicazione, ossia per via culturale. […] La cultura è tutto ciò che non deriva automaticamente da quello che il patrimonio genetico ci mette a disposizione, è tutto ciò che sappiamo fare, ma non riusciamo a trasmettere per via genetica, e che riusciamo invece a trasmettere o perché ne parliamo o perché lo facciamo e, facendo, insegniamo a farlo, insomma tutto ciò che è oggetto di un insegnamento e di un apprendimento».
Esattamente, puntualizziamo: tutto ciò che è oggetto di un insegnamento e di un apprendimento legata al mondo del vitale e al ‘solo mondo umano’. Ecco perché quando la cultura perde spazi, siano essi fisici o virtuali, sparisce anche la sua voce. Perché la voce è essa stessa parte dell’umano.