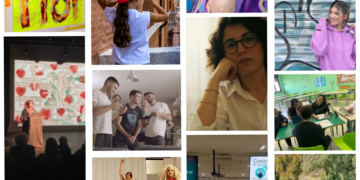“La calda vita” è un film del 1963 di Florestano Vancini, qui più intimista e crepuscolare, lontano dal suo cinema impegnato e politico, con Catherine Spaak, Jacques Perrin, Fabrizio Capucci e Gabriele Ferzetti.
Era l’estate dei primi anni ‘60, rovente e lunga come solo quelle che quest’isola ci sa regalare. Il cemento ancora non aveva invaso le coste sarde e tra le dune bianche di Villasimius al profumo di ginepri, lentischi e salsedine e una Cagliari che ancora appariva poco o niente al cinema, finisce l’età dell’innocenza di tre adolescenti che si affacciano alla vita adulta.
La trama.
Sergia, una disinvolta e vitale diciottenne, è alla Bussola, un locale sulla spiaggia del Poetto, con la sorella maggiore e la sua compagnia di quasi adulti in odor di vita borghese. Ballano, litigano, vola uno schiaffo. Tornata a casa, annoiata e inquieta, il mattino seguente accetta una fuga architettata dai due suoi amici Freddy e Max, entrambi innamorati di lei, che fingono di avere una casa a loro disposizione lasciata da un fantomatico zio ma che in realtà occupano abusivamente, una villetta sperduta e apparentemente disabitata su un’isoletta, per concupire entrambi la loro giovane e disinibita amica. Come spesso accade a quell’età, in un istante da amici si può diventare rivali, con quella rabbia sgraziata ma vitale tipica delle storie di formazione. Arrivati alla casa (le scene sono girate tra Porto Giunco, Capo Carbonara, Capo Boi e lo stagno di Notteri), Sergia gioca con entrambi, un po’ per civetteria e un po’ per una incosciente innocenza, si avvicina e si allontana, sospira silenziosamente e poi corre veloce, un po’ si dà e un po’ si ritrae. I due amici sono invece simili ma diversi, uno più spaccone ma fragile, l’altro più maturo e gentile. C’è ancora tutta la freschezza della gioventù, i diabolici piani di conquista dei due ragazzi, gli scherzi, le capriole sulla sabbia bollente, le bottiglie di vino senza bicchieri: ma il futuro e la crescita sono in agguato, con quel mal di vivere intrinseco e impalpabile che tutti abbiamo sentito almeno una volta, la voglia di diventare grandi che è al tempo stesso un doloroso cambio di pelle che da un giorno all’altro ci trasforma e ci rende nuovi ai nostri stessi occhi.
Nella loro quieta e drammatica fuga arriva il vero proprietario della casa, Guido, un quarantenne affascinato da Sergia nella quale rivede un passato libero da vincoli, anche lavorativi, che per lui ormai non può più tornare, un passato dove ancora tutto si può costruire, senza gli errori e le esperienze che l’hanno portato ad essere un uomo disilluso e malinconico, ancora teneramente aggrappato alla vita ma senza più le speranze e l’ardore della giovinezza. Gli equilibri sono sottili come lame, i tre amici si fanno guidare dall’uomo che ha tanti aneddoti da raccontare, si fidano e si divertono con lui, ma tutto precipita perché Sergia si invaghisce di Guido e decide di passare la notte con lui, si toglie il peso di quella verginità taciuta che da giovani ci hanno fatto pesare come un macigno, una tappa importante spesso solo perché l’ha deciso la società, quella società che Sergia rivede in sua sorella e che rifiuta, che prevede che la donna si debba sistemare alla prima occasione buona. Erano gli anni del boom, la società stava cambiando e si stava aprendo ma le aspettative erano ancora retrograde e bigotte (spesso lo sono ancora adesso). Era la società del benessere, della dolce (e qui anche calda) vita che si portava già appresso l’ombra dell’arricchimento che spesso svuota le esperienze e crea alienazione, dell’incomunicabilità descritta magistralmente da Michelangelo Antonioni, ferrarese anche lui come Florestano Vancini.
Il giorno dopo la fatidica notte in cui per i protagonisti tutto cambia, il cielo è già diventato grigio, la fine dell’estate è palpabile e così anche il dramma che cambierà le vite di tutti. Qualche tempo dopo, sulle scale della basilica di Bonaria, la sorella di Sergia si sposa, senza trasporto né convinzione, ma finalmente tranquilla di aver allontanato la solitudine apparentemente solo grazie a un contratto, il matrimonio. Sergia e Guido passeggiano al Bastione, che domina una soleggiata ma ormai autunnale Cagliari, i toni sono più sommessi e le voci aspre e urlate dell’adolescenza hanno lasciato spazio a discorsi fievoli e sussurrati. Guido chiede a Sergia di sposarlo, quasi come per riparare le conseguenze nate da quella notte d’estate, ma lei rifiuta: ha capito il pericolo in cui aveva rischiato di inciampare, una vita precostruita, infiocchettata più per gli altri che per noi stessi, senza amore, o almeno, senza quell’amore folle che lei ancora vuole cercare, senza accontentarsi.
All’aeroporto di Elmas i due si salutano e lei parte, libera e indipendente, certo anche un po’ triste, ma forte, sulle note malinconiche di un brano di Carlo Rustichelli cantato dalla stessa Spaak. “Non è niente, non è niente, è soltanto questo amore“.